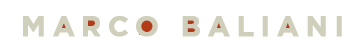Nulla più che la pubblicità permette di capire in che società viviamo.
La pubblicità è uno specchio spietato del modo di vivere, con la pretesa di indirizzarlo in certe direzioni, saggiandone le consistenze, per poi subito abbandonarle quando si scoprono improduttive.
Alla base ci sono due concezioni indissolubili. Uno: lo spettatore è un cliente consumatore e non un cittadino. Due: il Mercato ne è la religione, con i suoi riti, le sue formule magiche (gli indici di borsa ad esempio), i suoi comandamenti, che però non si fissano immutabili nel tempo ma cambiano velocemente a seconda del vento che tira.
Mai come in questi tempi di pandemia si è sentita pronunciare ad ogni piè sospinto pubblicitario la parola sostenibilità, parola feticcio, un mantra che non si sa cosa contenga ma che promette una parvenza di futuro, che vorrebbe infondere sicurezza, molto gettonato infatti anche nelle forme pubblicitarie della politica.
La sostenibilità ha superato in presenza perfino i gettonatissimi attributi bio, naturale, ecologico.
La pandemia ha generato una sorta di sovranismo provinciale, un restringersi e contarsi e contrarsi nel proprio orticello, mai tanta Italia e italiano hanno accompagnato merci e prodotti, come marchio di garanzia, di contrada, di paese, di comune e di regione, con i governatori o i sindaci che sempre più assomigliano a dei piccoli potentati, antagonisti gli uni agli altri, rispolverando antiche mai sopite tradizioni campanilistiche di un paese mai divenuto davvero nazione.
Come ai tempi delle invasioni barbariche, ci si rinserra nel contado, ci si isola dal mondo, affidandosi interamente al Principe di turno che saprà alzare i cancelli dei ponti levatoi prima che il nemico entri tra le mura.
Non sono tempi per offrire ponti (quelli che ci sono crollano per incuria) ma per innalzare muri (chiudendo confini, vietando vaccini a paesi stranieri, requisendo scorte).
I telegiornali ormai sono un inno alla siringa, mai visti tanti aghi iniettati in spalle o braccia, ossessivamente, anch’esse forme pubblicitarie che spingono al consumo dei vaccini, a fomentare scampoli di fiducia in un popolo stressato.
Vorrei in particolare soffermarmi su una pubblicità che mostra un bambino che si costruisce una casetta assemblando pezzi diversi di cartone, la colora e poi la trascina con una corda per mostrarla ai genitori.
La madre lo prende in braccio e stupita di fonte alla creazione del suo piccolo dice: “che bella, chissà quanto vale?”. Subito dopo arriva la voce suadente (sono sempre voci calde e vagamente erotizzanti sia che vendano auto sia che promuovono cioccolata, coi profumi poi siamo all’orgasmo) che induce la coppia di genitori a sfogliare le promozioni di una immobiliare che al volo dice quanto vale ogni singola casa del pianeta Italia. La battuta della madre è semplicemente mostruosa, però perfettamente in sintonia con la galoppante mercificazione di ogni atto, di ogni gesto del vivere sociale. La casetta del piccolo costruttore è un’opera d’ingegno, artigianalmente faticata e sofferta, che ha richiesto del tempo per essere realizzata.
La mamma insegna al bambino che ogni gesto culturale, da quel suo gioco infantile fino ad un’opera d’arte, ha senso solo se ha un valore economico, lo sta educando al suo prossimo futuro.
In ogni città esistono caveau dove sono segregate, sotto custodia e sorveglianza, opere d’arte che nessuno vedrà mai, esse non sono più un valore d’uso per la comunità, ma un bene rifugio per i loro proprietari, come fossero lingotti d’oro nelle cassette di sicurezza di una banca. In effetti sono la stessa cosa, sono scambiabili.
Il beneavere del portafoglio impedisce il vero dispiegarsi del benessere, che non si manifesta immergendosi in qualche bagno termale da cartolina illustrata, o richiudendosi in qualche crociera mediterranea, ma nello “stare bene” con sé stessi, dentro il mondo, in mezzo agli altri e con gli altri.
Questa pandemia ha accentuato, ancor più nei bambini e negli adolescenti, una percezione del mondo già confezionata, una direzione dello sguardo e del sentire che non ha più a che fare con la realtà delle cose che ci circondano, massimamente poi di quelle che hanno a che fare col mondo vegetale e animale, ma che si riferisce solo a ciò che può entrare in uno schermo.
Avremmo un disperato bisogno di altri occhi e di altri sensi, poter avere gli occhi di Andrey Rublev, il monaco pittore di icone, che, a sera, aveva gli occhi stanchi, sfiniti dal tanto contemplare la “straziante bellezza del creato” in ogni sua più minuta manifestazione di esistenza.