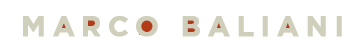Le memoria di Gina Negrini (Sole Nero, Cappelli, Bologna 1969) trasmettono il percorso significativo di una giovane operaia bolognese, segnato dalla Resistenza. Coinvolto nelle tragedie del mondo – il nero – Gina sentì allora possibile un cambiamento radicale – il sole -, si produsse così oltre a una persistente passione politica, un bisogno di creatività che si sarebbe espresso anche nella pittura.
Aveva diciotto anni quando partì nel settembre 1944. Quell’appuntamento lo aveva fortemente voluto: le sofferenze patite in collegio come figlia illegittima e poi le fatiche mal retribuite in una piccola fabbrica avevano temprato il suo carattere; la disperazione l’aveva portata a volere tanto ardentemente un’altra realtà, che arrivava a “sdoppiarsi”. Ed entrando in una base “gappista” effettivamente iniziò una seconda vita, assumendo come nome di battaglia Tito, per ammirazione nei confronti di un “guerriero che aveva fatto tutto da solo”, senza aspettare l’aiuto degli Alleati.
Il desiderio di essere indipendente le veniva dalle donne della sua famiglia: dalla nonna autodidatta, dalla zia Armida che aveva sparato ai fascisti per difendere il fratello e si era gettata in un macero per non sposarsi, dalla madre amatissima che le aveva insegnato il piacere dei libri.
Quando la sede della brigata, occupata dai repubblichini, divenne teatro di una sanguinosa battaglia, Gina Negrini rischiò la vita per salvare un compagno ferito e poi scampò miracolosamente alla morte, ricorrendo alla simulazione.
Allontanatasi dal luogo del massacro, si lasciò andare in un fosso, mestruazioni improvvise le ricordarono allora il confine oltrepassato dalla morte alla vita, da una condizione estrema alla sua “natura” di donna. Entrò poi nel Comando Divisione Staffette e nell’aprile 1945 fu arrestata: “per non parlare” cancellò la sua memoria. Può capitare quando “uno ha una volontà molto forte”.
La sua Resistenza fu un insieme di esperienze assolute, a cui era difficile dare un seguito altrettanto avventuroso. Elaborò un nuovo sogno, andare nella patria del socialismo. Sposò un giovane russo che la convinse a lasciare l’Italia e insieme furono bloccati in un campo di concentramento e lei sola fu rimandata indietro.
Qui termina il libro: Gina, che aveva la licenza elementare, aveva deciso di scrivere per reagire alla situazione familiare che la mortificava (si era risposata nel 1949) e a una malattia che la minacciava. “Non volevo – dice – che morisse con me quella ragazza che ero stata, volevo che qualcuno poi negli anni leggendomi l’avesse fatta resuscitare”.
Ora un’attrice fa resuscitare quella ragazza che il libro ha fissato e Gina Negrini può rivedersi partigiana non solo in un gioco solitario fra sé e la pagina da riempire: il suo teatro mentale di memoria si materializza e dalla lontananza di quel passato nasce fisicamente un’altra Gina. Le dà corpo Maria Maglietta, un’attrice potente che ha saputo legare teatro e politica, teatro e vita, e si è distinta per come ha lavorato creativamente su relazioni femminili e su vissuti memorabili, a noi contigui. Tra biografia e sua recitazione in scena si verifica necessariamente un salto mortale, e il problema non è immediatamente riconoscersi e riconoscere. Mettere in scena un libro, ritrovare l’energia sepolta nella storia: a queste sfide il teatro è abituato e in particolare quello impegnato di Baliani e Maglietta; ma per Maria non si è trattato tanto di collegare diverse generazioni di donne attraverso un nodo centrale per l’Italia in un secolo di fatto già concluso, quanto di rintracciare fili più sottili di una tela comune che ancora andiamo intrecciando.